Cosè la Chimiurgia?
Chemiurgia (
Chemurgy in
inglese, dal
greco chemeia «chimica» ed
ergon «lavoro») è un termine nato in
America negli
anni trenta
per definire quella branca dell'industria e della chimica applicata che
si occupa della preparazione dei prodotti industriali esclusivamente da
materie prime agricole e naturali, facendo uso solamente di
risorse rinnovabili e senza recare danno all'
ambiente.
La parola fu coniata dal chimico
William J. Hale, che nel
1934 pubblicò il libro
The Farm Chemurgic, per indicare «l'ottenimento di sostanze chimiche industriali dai prodotti agricoli».
Negli
anni trenta, di fronte all'avanzare della
rivoluzione industriale, il movimento della
Chemiurgia
si proponeva di trasformare ed integrare la produzione agricola con
quella industriale, invece di abbandonare l'agricoltura a se stessa
indirizzando tutti gli investimenti sull'industria. La chemiurgia
puntava dunque ad usare prodotti
vegetali, in particolare la
canapa, pianta coltivata e diffusissima in America fino al suo
proibizionismo,
che era in grado di fornire all'industria grandissima parte delle
materie prime di cui necessitava e che oggi si ricavano in gran parte
dalla lavorazione del
petrolio.
« Perché consumare foreste che hanno impiegato secoli per crescere e
miniere che hanno avuto bisogno di intere ere geologiche per stabilirsi,
se possiamo ottenere l'equivalente delle foreste e dei prodotti
minerari dall'annuale crescita dei campi di canapa? »
Restava però ancora un pesante handicap per rendere la produzione di
cannabis
davvero competitiva. Il lavoro di separazione della fibra infatti
andava fatto a mano, e questo rallentava notevolmente i tempi e i costi
di produzione. L'invenzione di una nuova macchina, il "
decorticatore", sembrò poter togliere questa barriera alla produzione industriale della
cannabis, e delle altre fibre tessili ricavate dal fusto delle piante, prospettandone un successo pressoché illimitato. La rivista
Popular Mechanics pubblicò in quei mesi un articolo intitolato
"La nuova coltivazione da un miliardo di dollari", nel quale si prospettava uno strepitoso rilancio a livello mondiale delle piantagioni di
cannabis.
[4]
Tuttavia queste premesse non poterono essere confermate, a causa delle
leggi di proibizione che già nel
1937 vennero applicate alla coltivazione e al commercio della
cannabis.
Alcuni ritengono che la proclamazione di queste leggi di proibizione nei confronti della
cannabis negli
Stati Uniti sarebbe stata legata alla concorrenza tra la nascente
industria petrolchimica dei prodotti
DuPont e la possibilità di usare l'olio di questa pianta per produrre
fibre plastiche e come combustibile, ed altresì alla concorrenza della nascente
industria della carta ricavata dal legno degli alberi, sminuzzato e sbiancato con
sostanze chimiche, con la eventuale produzione industriale di
carta di canapa.
[5] Inoltre, il magnate del
giornalismo William Randolph Hearst, uno dei più importanti sostenitori del
proibizionismo della cannabis
proprio con i suoi quotidiani, aveva acquistato milioni di ettari di
foresta da legname, che intendeva utilizzare per produrre carta appunto
per i suoi giornali, sempre più popolari.
[6]
I principi della chemiurgia sono tornati alla ribalta negli
ultimi anni, trattati con approcci diversi e soprattutto identificati
con nuovi nomi, come nel caso della
chimica verde.
MATERIE PRIME DI ORIGINE AGRICOLA COME FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO PER L'INDUSTRIA
Ottilia De Marco
Professore emerito, Università di Bari
La
biomassa vegetale ha fornito da sempre materie prime all'industria
alimentare, tessile, navale, edilizia, cartaria, dell'arredamento ecc.
Con
l'avvento dell'industria petrolchimica e l'affermazione sul mercato di
altri materiali, alcune di tali industrie hanno tratto da altre fonti le
loro materie prime, lasciando l'industria alimentare come sbocco
prevalente della produzione vegetale. Il settore agricolo, d'altra
parte, ha fatto troppo poco per incentivare e sviluppare l'uso dei suoi
prodotti e sottoprodotti come materie prime industriali, pertanto si è
avuta una stasi negli studi e nelle ricerche su queste sostanze.
Così,
mentre le conoscenze nel campo petrolchimico e dei nuovi materiali si
sono ampliate e approfondite, quelle riguardanti i prodotti vegetali
sono ancora molto lacunose. Eppure le ricerche su questi argomenti oltre
ad essere stimolanti per il fascino che sempre esercita la possibilità
di scoprire i meccanismi di formazione dei prodotti della natura e le
leggi che li governano, suscitano interesse sia per l'enorme
disponibilità di tali materiali, sia per le applicazioni pratiche che da
una loro profonda conoscenza possono derivare.
Ogni
anno, col processo fotosintetico, vengono fissati sulle terre emerse
circa 100 miliardi di tonnellate di carbonio, per circa due terzi sotto
forma di materiali lignocellulosici e per circa un terzo sotto forma di
amido, zuccheri e altre sostanze.
Nel
passato, in un periodo di crisi, ci fu, negli Stati Uniti, un breve, ma
intenso interesse per la trasformazione dei prodotti naturali in
prodotti industriali. Agli inizi degli anni venti, infatti, William J.
Hale, un chimico della Dow Chemical Co., lanciò un vasto movimento
sociale, denominato Farm Chemurgic Movement, che aveva come obiettivo
l'utilizzazione, nell'industria chimica, di materie prime derivanti
dall'agricoltura.
Il
termine chemurgia fu coniato dallo stesso Hale, dal greco chemeia
(chimica) ed ergon (lavoro), per indicare l'ottenimento di sostanze
chimiche industriali dai prodotti agricoli.
Il
movimento attrasse l'attenzione e l'interesse di molti uomini
importanti, a livello politico come Henry Wallace (ministro
dell'agricoltura nella prima amministrazione Roosevelt, 1933), a livello
industriale come Henry Ford e, a livello intellettuale come George
Washington Carver (1865-1943), che si impegnarono a fondo in questa
operazione. Molte idee nuove furono realizzate e molti studi furono
condotti, nei settori più vari.
Negli
anni trenta del Novecento, presso il Dipartimento dell'agricoltura
degli Stati Uniti, furono istituiti quattro laboratori "chemurgici"
regionali che divennero i maggiori centri di ricerca e di applicazione
dei prodotti e sottoprodotti agricoli, soprattutto di quelli più
ampiamente disponibili o dei quali si registravano regolarmente o
stagionalmente delle eccedenze.
Henry
Ford, oltre a finanziare i primi Convegni del National Farm Chemurgic
Council, istituì a Dearbon, vicino a Detroit, un centro di ricerca sui
prodotti agricoli, chiamato Edison Institute of Technology: uno dei
primi e più importanti programmi di studio fu quello riguardante la soia
.
Fra
le realizzazioni della chemurgia va ricordata la produzione del
furfurolo dalla pula di avena nello stabilimento di Omaha (Nebraska)
della Quaker Oats; quando lo stabilimento fu chiuso, in seguito alla
crisi del 1932, la riapertura fu determinata proprio dalla domanda di
furfurolo e non da quella di farina di avena.
Altro
esempio di applicazione industriale, dovuta alle ricerche effettuate in
campo chemurgico, fu quello dell'uso del legno del pino meridionale per
l'ottenimento di alfa cellulosa, sulla base degli studi condotti da
Charles H. Herty. L'impiego di questa pianta portò alla nascita e allo
sviluppo, nella parte meridionale degli Stati Uniti, dell'industria
della cellulosa e della carta che precedentemente era accentrata nel
nord e nord est del paese, alimentata con piante a crescita più lenta.
Questo
fervore di idee e di iniziative fu interrotto dallo scoppio della Il
guerra mondiale. In seguito, l'ampia disponibilità di petrolio a prezzo
molto basso fece apparire economicamente poco conveniente
l'utilizzazione di prodotti agricoli per l'ottenimento di sostanze
chimiche industriali. Negli anni settanta del Novecento la crisi
dell'energia e delle risorse e il degrado ambientale sembrarono
riportare l'interesse verso la ricerca di nuove materie prime meno
costose, più disponibili e suscettibili di trasformazione in merci meno
inquinanti. Si cominciò a guardare con una certa attenzione alle fonti
naturali, rinnovabili, alla cosiddetta biomassa. Da allora, però, pochi
settori, come ad esempio quello della produzione dell'alcol per
fermentazione e della sua utilizzazione come carburante, sono stati
oggetto di studio e di sperimentazione industriale.
Il
lavoro che resta da fare è perciò ancora molto e l'impegno di ricerca,
che dovrebbe essere interdisciplinare, potrebbe portare a risultati di
enorme interesse in vasti settori economici. Si indicano qui di seguito
alcune linee di ricerca rivolte all'approfondimento delle conoscenze di
base dei materiali vegetali, in vista di una loro migliore utilizzazione
industriale.
Amido
L'amido
è uno dei più abbondanti materiali vegetali: per fotosintesi se ne
producono circa 50 miliardi di tonnellate l'anno, ma la produzione di
amido industriale, nel mondo, si aggira, soltanto, intorno ai 20 milioni
di tonnellate l'anno. È ricavato per il 75% dal mais e per il resto da
grano, riso, patate, tapioca ecc.
A
seconda della specie o della famiglia da cui proviene, esso presenta
caratteristiche diverse tanto che si deve parlare dell'esistenza di
"amidi" (al plurale), piuttosto che di amido. Una rassegna delle
caratteristiche degli amidi presenti nei vari vegetali, con particolare
attenzione alle piante che sono state finora poco utilizzate come fonti
industriali di amido, potrebbe rappresentare un interessante argomento
di ricerca. Sulla base dei risultati si potrebbe giungere ad una vera
classificazione degli amidi e ad una eventuale loro più specifica
utilizzazione.
Un
secondo argomento di ricerca potrebbe essere lo studio dei complessi
molecolari amido-lipidi e amido-proteine, presenti nelle diverse piante.
La conoscenza della natura di questi complessi potrebbe fornire forse
anche la spiegazione di certi fenomeni, come ad esempio, il rinvenimento
del pane raffermo o il diverso comportamento alla macinazione del
grano, del granoturco e del riso.
Sarebbe
inoltre interessante approfondire la conoscenza del rapporto
amilosio/amilopectina, i due costituenti dell'amido, il cui contenuto di
solito è del 15-30% per l'amilosio e del 70-85% per l'amilopectina, ma
che può variare nelle diverse piante con conseguente modificazione delle
caratteristiche dell'amido.
Derivati
importanti dell'amido sono, come è noto, le destrine e le ciclodestrine
che, a secondo della loro provenienza o del loro processo di
preparazione, manifestano proprietà particolari che le rendono adatte a
varie applicazioni (come adesivi, emulsionanti, leganti, assorbenti
ecc.) in settori merceologici diversi (alimentare, tessile, cartario,
metallurgico ecc.).
Una
ricerca approfondita sulla struttura di queste sostanze, di cui si sa
ancora molto poco, potrebbe fornire suggerimenti per un impiego più
vasto.
Zuccheri
Fra
gli zuccheri, sostanze ampiamente diffuse in natura, il più
commercialmente usato, come è noto, è il saccarosio che viene estratto
principalmente dalla canna e dalla barbabietola e il cui impiego
prevalente è quello alimentare.
Il
valore potenziale del saccarosio come materia prima per l'industria
chimica è stato spesso oggetto di ricerca, ma le applicazioni pratiche
sono ancora molto limitate. La sua struttura chimica di alcol poliidrato
favorisce reazioni selettive a seconda del gruppo idrossilico, primario
o secondario, e a seconda della posizione di questo nella molecola.
Generalmente i gruppi idrossilici primari sono i più reattivi. La
differente reattività dipende anche da altri fattori come il tipo di
solvente che si usa, il tipo di reazione, la temperatura ecc.
Tutto
questo consente molteplici sostituzioni e una potenzialità di derivati
quasi infinita. Del saccarosio sono noti alcuni esteri, eteri, acetali e
uretani anche se le conoscenze di tali derivati sono ancora scarse. I
gruppi idrossilici primari possono essere ossidati ad aldeidi o ad acidi
carbossilici e i gruppi idrossilici secondari a chetoni. I gruppi
idrossilici possono essere sostituiti anche da idrogeno, da alogeni, da
tiocianati, da tioacetati o da altri gruppi monovalenti.
Nonostante
queste ampie possibilità di produzione, i derivati del saccarosio che
hanno finora avuto un sia pur limitato interesse, anche dal punto di
vista commerciale, sono stati gli esteri che hanno trovato utilizzazione
come sostanze tensioattive ed emulsionanti nell'industria dei
detergenti, dei cosmetici e in quella alimentare.
Anche
derivati di altri zuccheri come il sorbitolo e il lattitolo (alcoli
ottenuti per idrogenazione catalitica, rispettivamente, del glucosio e
del lattosio), esterificati con acidi grassi, hanno mostrato buone
proprietà detergenti disperdenti e umettanti.
Il
campo di indagine nel settore degli zuccheri è ancora molto vasto e può
riservare interessanti successi. Non sono stati qui presi in
considerazione, ad esempio, tutti i processi basati sulla fermentazione
la cui tecnologia, per certi prodotti, è già nota perché ampiamente
usata prima dell'avvento della petrolchimica, ma che andrebbe, tuttavia,
approfondita e sviluppata.
Grassi
Un'altra
possibile fonte di materie prime per l'industria chimica sono i grassi.
Essi sono già usati nell'industria dei saponi e dei cosmetici e trovano
buona applicazione nell'industria dei detergenti, per la produzione di
acidi grassi, "alcoli detergenti", metilesteri e loro derivati, sostanze
intermedie per l'ottenimento di tensioattivi.
La potenzialità d'uso dei grassi è però molto grande. Già nel periodo chemurgico e durante la Il guerra mondiale sono stati impiegati per la produzione di idrocarburi e di oli combustibili.
I
grassi, come del resto quasi tutte le sostanze naturali, si
differenziano a seconda della loro provenienza ed esplicano particolati
proprietà. Così l'olio di lino presenta proprietà siccative, quello di
ricino proprietà lubrificanti per i motori. La presenza in quantità
elevata di acido erucico nell'olio di crambe lo rende adatto a fornire
un lubrificante specifico per i convertitori ad ossigeno, usati per la
trasformazione della ghisa in acciaio. L'olio di jojoba, per la sua
composizione di estere di un acido grasso con un alcol grasso, è
risultato un valido sostituto dell'olio di capodolio, tradizionalmente
usato come lubrificante e ormai molto raro sul mercato.
Indagare
sulle caratteristiche dei grassi, presenti nei semi o nei frutti delle
piante più comuni, ma soprattutto di quelle meno diffuse o di recente
coltivazione, può essere un altro importante impegno scientifico per i
ricercatori.
Proteine
Le
proteine, molecole complesse fondamentali alla vita, costituiscono una
buona parte del contenuto cellulare delle piante e degli animali.
Molte
delle tecnologie tradizionali dipendono dalle proprietà delle proteine.
La bontà del pane è legata alla presenza, nelle farine, del glutine che
serve a formare un reticolo elastico che trattiene l'umidità e il gas e
rende il pane soffice e fragrante. Anche i sapori e gli odori dei cibi
dipendono, spesso, dal comportamento delle proteine durante la cottura.
La
struttura delle proteine è molto complessa; molti studi sono stati
condotti e i risultati più importanti si sono avuti a partire dagli anni
'40, ma soprattutto dopo la seconda guerra mondiale. Tuttavia, le
combinazioni con le quali i 20 aminoacidi, presenti nelle proteine,
possono legarsi fra loro sono COSI numerose e tali da rendere ogni
molecola proteica unica; varrebbe la pena, perciò, di approfondirne la
conoscenza.
Nel
periodo chemurgico la parte solubile in alcol del glutine di mais, la
zeina, trovò applicazione industriale per la produzione di vernici e di
fibre tessili. Altri tentativi, in seguito, per l'ottenimento di fibre
tessili, sono stati fatti con le proteine della soia e delle arachidi.
Il prodotto è risultato poco soddisfacente e la tecnologia è stata
utilizzata poi per l'ottenimento di carne di soia.
Recenti ricerche suggeriscono l'impiego di proteine per la preparazione di sostanze tensioattive e di materie plastiche.
Lignocellulosa
Il
materiale lignocellulosico è uno dei derivati della biomassa impiegato
quasi esclusivamente nell'industria, soprattutto nell'industria delle
costruzioni e dell'arredamento e in quella della cellulosa e carta.
Questo
materiale, tratto per la maggior parte da alberi di alto fusto, può
essere ottenuto anche da residui di altre piante minori che spesso
vengono trascurati. È un materiale complesso in cui sono presenti oltre a
cellulosa, lignina, emicellulosa, altre sostanze come acidi grassi,
resinici, tannini, gomme ecc.
Nell'industria
della carta, durante la preparazione delle paste al solfito e al
solfato, si ha come sottoprodotto il lignosulfonato, una miscela di
lignina sulfonata, di zuccheri, di acidi degli zuccheri, di resine e di
sostanze chimiche inorganiche.
Il
lignosulfonato è un'importante materia prima usata per la produzione di
vanillina ed è suscettibile di altri impieghi in vari settori
industriali: come tensioattivo nell'industria dei detergenti, come
legante per pellets, come additivo nei cementi ecc.
Durante
la lavorazione della pasta al solfito e al solfato, quando si usa legno
di pino; dalla soluzione che si ottiene dopo la cottura del legno, il
cosiddetto liscivio nero, si può ricavare anche il tallolio, costituito
per il 48% da acidi grassi e per il 42% da acidi resinici che possono
essere separati per distillazione e destinati a vari usi. Sempre nella
preparazione delle paste da carta, durante la cottura del legno si ha la
formazione di acido acetico e alcol metilico che spesso vengono
scaricati con gli effluenti liquidi, creando problemi ambientai i che
potrebbero essere evitati recuperando questi prodotti.
La
carbonizzazione del legno porta sempre, infatti, alla liberazione di
questi due componenti insieme a catrame e ad altre sostanze, tutte
utilizzabili industrialmente.
Per
idrogenazione o idrolisi della lignina si può ottenere una frazione di
sostanze aromatiche e fenoli. Per idrolisi acida del legno si ha fra
l'altro, una soluzione di pentosi, esosi, acido formico, acido acetico
ecc. I pentosi possono essere convertiti in furfurolo.
Va
inoltre ricordato l'ampio campo di utilizzazione della cellulosa da cui
si ottengono numerosi derivati, come gli acetati, gli xantati, la
carbossimetilcellulosa ecc..
Il
materiale lignocellulosico, per la varietà e la ricchezza dei suoi
componenti è una risorsa naturale che offre enormi prospettive.
Adeguatamente impiegato può fornire la maggior parte delle merci oggi
ottenute dal petrolio.
Anche
da una cosi rapida rassegna, si può vedere come le materie prime di
origine agricola possono rappresentare per l'industria una fonte di
approvvigionamento costante, rinnovabile, poco costosa, non esposta a
grossi giochi di mercato.
Perché
l'industria possa utilizzare al meglio queste risorse che, se anche
rinnovabili, non devono essere sprecate, ha bisogno di conoscere
profondamente la loro composizione, la loro struttura e la loro
disponibilità, la loro potenzialità di impiego.
È
necessario che i laboratori delle università, degli enti pubblici,
delle industrie sviluppino programmi di ricerca sui prodotti e
sottoprodotti agricoli. L'agricoltura, da parte sua deve incentivare
l'uso dei suoi prodotti, con colture adeguate, scegliendo per
l'utilizzazione industriale piante adatte allo scopo, con
caratteristiche particolari, creando ibridi ecc.
Hale
nel 1946 concludeva cosi un suo articolo intitolato: The Farm Chemurgic
Movement. "Il Farm Chemurgic Movement si pone come obiettivo quello di
avere una agricoltura fiorente alla pari e in concorrenza con una
industria altrettanto fiorente, entrambe condotte su basi scientifiche e
in grado di fornire occupazione a tutti i cittadini".
È ancora oggi un obiettivo da perseguire.



 La presenza batterica comunque è efficacemente contrastata dai nostri anticorpi che ci difendono dagli attacchi, a patto che:
La presenza batterica comunque è efficacemente contrastata dai nostri anticorpi che ci difendono dagli attacchi, a patto che:
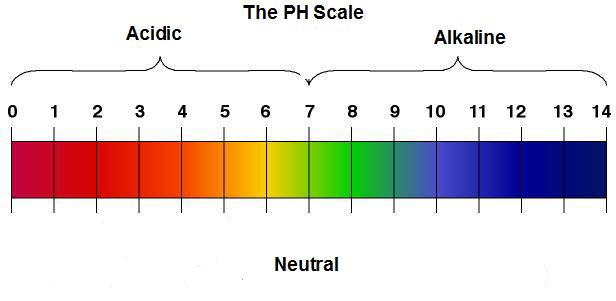
.jpg)


